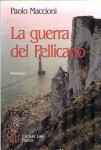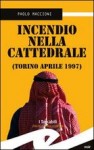Unu meledu subra sas raighinas istoricas de sa Natzione sarda, s’Indipendentzia e s’imbrolliu de s’Unidade de s'Italia.
di Francesco Casula
1.Nazione
Nel medioevo il termine “nazione”, per esempio per Dante “e sua nazione sarà fra feltro e feltro” (1)- indica la città: fra la città di Feltro e Montefeltro appartenenti a Cangrande della scala).
Nel basso medioevo la parola dal latino natus comincia ad essere usata per indicare gruppi umani accomunati dalla provenienza geografica: gli studenti nelle università; le sezioni territoriali dei delegati al Concilio di Costanza (1414-1418). Ancora nel secolo XVIII in Italia è impiegata per designare la comunità politica cittadina o regionale, la comunità di lingua letteraria; l’Europa intesa come comunità di cultura. Solo nel secolo XIX viene a indicare un tipo specifico di comunità politica fondata su tradizioni storiche, lingua e costumi condivisi.
Ma il concetto di nazione è uno dei più controversi della scienza politica e della storiografia. I punti di maggior controversia riguardano la diversa importanza attribuita ai fattori oggettivi e soggettivi che costituirebbero la nazione nonché la natura del nesso fra nazionalità e statualità.
a) Nazione come fatto oggettivo:
Fu J. G. Herder, considerato precursore del romanticismo, nel secondo ‘700 a sostenere la tesi che le nazioni rappresentano delle entità nettamente diverse per caratteri loro propri, fra cui essenziali sono il sangue, il territorio e la lingua. L’origine etnica delle Nazioni è stata sostenuta anche recentemente. Ma è soprattutto sulla Lingua che insistono i sostenitori della Nazione come entità obiettiva.Insistette con particolare forza il filosofo tedesco J. G. Fiche, per il quale “dovunque si trovi una lingua distinta esiste anche una nazione separata che ha il diritto di regolare i suoi affari e di autogovernarsi” (2).
E’ la posizione romantica espressa poeticamente dal Manzoni ”Una d’arme di lingua d’altare/di memorie di sangue e di cor” (3)
b) Nazione come fatto soggettivo
A un secondo filone teorico appartengono invece le dottrine che interpretano la Nazione come un fatto di coscienza e di intenzionalità, quelle che F. Chabod (4) raccoglie sotto il termine di “volontaristiche”. In realtà Chabod traccia un’idea di carattere prevalentemente burocratico-amministrativo senza dare alcun rilievo all’elemento territoriale e a quello della lingua per esempio.
La formulazione più famosa della teoria “volontaristica” è quella contenuta nella conferenza di E. Renan (Qu’est ce qu’est une nation?, 1882): “un pebliscito di tutti i giorni …il consenso, il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme”.
c)Nazione come prodotto della politica. In Italia M. Albertini (5) ha sostenuto che “lo stato centralizzato non poteva sussistere senza creare l’idea di un gruppo tanto omogeneo quanto era concentrato il potere. D’altra parte ne aveva i mezzi: la scuola di stato, il servizio militare obbligatorio, i grandi riti pubblici, l’imposizione a tutte le città, per diverse che fossero, dello stesso sistema amministrativo e della tutela prefettizia”.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1) Dante, “Inferno, verso 105”
2) J. G. Ficte, “Discorsi alla nazione tedesca, 1807/8)
3) Alessandro Manzoni “lirica Marzo 1821, versi 31-32”
4) Federico Chabod “L’idea di nazione, 1961”
5) Mario Albertini “Lo stato nazionale, 1960”
2. La “nazione Italiana” ovvero lo Stato unitario, centralista e accentrato.
Nonostante la posizione di Cavour, che avrebbe preferito il sistema anglosassone del self-gouvernement e non il modello franco napoleonico, cui si rifaceva sostanzialmente l’ordinamento piemontese, è la scelta di stato unitario e accentrato ad imporsi con il Risorgimento italiano.
Essa è nel contempo, secondo lo storico marxista Ernesto Ragionieri (1), “specchio e indice dei rapporti di classe allora esistenti” e si ricollega – secondo Giorgio Candeloro (2)- alla “ristrettezza del ceto politico risorgimentale identificabile nell’alleanza della borghesia agraria-mercantile-bancaria centrosettentrionale con quella terriera del Sud comprendenti entrambe la maggioranza dei ceti aristocratici, più o meno imborghesiti, delle varie Regioni”. Quell’alleanza che Antonio Gramsci (3) identificava sostanzialmente nel “blocco storico” composto della borghesia settentrionale e dal latifondo meridionale.
Tale ristrettezza è evidenziata esemplarmente dai dati elettorali: nel 1861 su un totale dell’1,9% degli aventi diritto al voto, votarono il 50-60% e un deputato veniva eletto con qualche centinaio di voti. Se causa di tale ristrettezza è la mancata rivoluzione agraria – invano auspicata e sostenuta da Filippo Buonarroti e Carlo Pisacane ma di fatto osteggiata e comunque boicottata dai democratici come lo stesso Mazzini e Garibaldi - e non solo, naturalmente, dai moderati – la conseguenza sarà uno sviluppo economico territorialmente e regionalmente squilibrato.
Infatti, a un modello di sviluppo economico che implica lo squilibrio territoriale, cioè il sottosviluppo di alcune parti del Paese – nella fattispecie la parte meridionale – è oggettivamente funzionale l’assenza di robuste Autonomie Locali. Infatti se i Governi regionali avessero tratto legittimazione da una investitura più vasta di quella denunciata dalla percentuale degli elettori – sopra citata – e fossero stati provvisti di potere di orientare le politiche e le economie locali in senso conforme agli interessi delle rispettive popolazioni locali, avrebbero potuto respingere un tipo di sviluppo che imponeva il sacrificio economico sociale dei loro territori.
Quel modello di sviluppo presupponeva quindi l’assenza di consistenti Autonomie locali. Di qui risulta chiaro il nesso e l’intreccio fra accentramento politico e amministrativo, modello di sviluppo e alleanze politiche di classe.
Tale scelta centralistica ha avuto ieri ed ha ancora oggi – sia pure molto meno - i suoi sostenitori, di parte conservatrice e liberale ma anche se non soprattutto - di parte progressista e di sinistra, a tal punto da avere imposto e da continuare ad imporre al senso comune l’idea dello Stato unitario e centralizzato come la forma più alta e moderna di ordinamento statuale.
Ogni altra soluzione diversa da quella centralistica e unitaria – ha sostenuto lo storico liberale Rosario Romeo (4) – sarebbe andata a vantaggio delle componenti clericali, perciò antiunitarie, filoborboniche e legittimiste. In altre parole concedere l’Autonomia rinunciando all’accentramento avrebbe significato - è lo storico Alberto Caracciolo (5) a sostenerlo – “trasferire una parte del potere a forze che erano antagoniste rispetto a quelle che avevano guidato l’unificazione politica e l’ordinamento regionale avrebbe rappresentato un pericolo per l’unità nazionale, tanto faticosamente raggiunta”. Forze e ceti che a causa dell’esiguità e della gracilità del tessuto sociale e culturale sarebbero intenzionati – sempre secondo Caracciolo – a “servirsene in senso regressivo”. Secondo un altro storico, sempre di matrice liberale, Carlo Ghisalberti (6) “ l’accentramento amministrativo è di per sé un dato progressivo, in quanto connesso alla linea di sviluppo dello stato moderno”. In altre parole lo Stato accentrato è visto come soluzione adeguata e necessaria per l’arretratezza della società dell’epoca. In altre parole l’organizzazione e l’assetto centralistico dello Stato è coerente con il modello di sviluppo che implica lo squilibrio territoriale in cui al sottosviluppo di alcune regioni è oggettivamente funzionale l’assenza di robuste autonomie locali. Infatti dei governi regionali che avessero tratto legittimazione da una investitura più vasta di quella denunciata dalla percentuale di elettori sopra citata, e fossero stati provvisti del potere di orientare la politica e l’economia locale in senso conforme agli interessi delle rispettive popolazioni, avrebbero potuto respingere e avrebbero respinto un tipo di sviluppo che imponeva e richiedeva il sacrificio economico sociale delle loro Regioni.
Quel modello di sviluppo presupponeva quindi come condizione necessaria – consapevoli o meno poco importa – l’assenza di consistenti autonomie locali.
Ma si sostiene l’accentramento anche sul versante politico di sinistra, spesso in modo identico, utilizzando persino lo stesso lessico e forse addirittura in forme ancora più nette e decise da parte dei grandi maestri e teorici illustri come Engels che sosteneva l’accentramento dello Stato unitario e indivisibile.” Il proletariato – affermava nel 1847 – può utilizzare soltanto la forma della repubblica una e indivisibile” e “non solo ha bisogno dell’accentramento com’è avviato dalla borghesia, ma dovrà addirittura portarlo più avanti”.
Per questo lo stesso Engels combatte il Federalismo “perché semplice espressione di anacronistici particolarismi provinciali”.
La tradizione engelsiana non influenzerà solo la sinistra ma tutto il senso comune progressista per cui l’idea dello Stato unitario e centralizzato sarà considerata la forma non solo più efficiente ma anche più alta e moderna, evoluta e giusta di ordinamento statuale; di contro, ciò che allo Stato unitario e centralista si oppone – il Federalismo – “appare come arretrato, regressivo, premoderno e residuale” (7).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1) Ernesto Ragionieri, “Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita” Bari 1967
2) Giorgio Candeloro, “Storia dell’Italia moderna. La costruzione dello stato unitario” vol. V, ed. Feltrinelli, Milano 1968
3) Antonio Gramsci, “Il Risorgimento”, Ed Einaudi, Torino 1955
4) Rosario Romeo, “Dal Piemonte sabaudo all’Italia liberale”, Torino 1963
5) Alberto Caracciolo, “La formazione dello stato moderno” Bologna 1970 e “Stato e società civile: Problemi dell’unificazione italiana” Torino 1960
6) Carlo Ghisalberghi, “Sulla formazione dello stato moderno in Italia” Milano 1967
7)Luigi Manconi, Unione Sarda 13.19-1983
3. La truffa del Risorgimento
All’inizio degli anni ’70, alcuni intellettuali fra cui Nicola Zitara, Anton Carlo e Cralo Capecelatro (di cui rimando, per i riferimenti bibliografici, al paragrafo 7 su Simon Mossa) –che verranno poi chiamati nuovi meridionalisti- furono tacciati brutalmente dall’Unità di essere filoborboni e reazionari. Avevano osato dissacrare quanto tutti avevano divinizzato: il movimento e il processo, considerato progressivo e progressista del Risorgimento; avevano osato mettere in dubbio e contestare le magnifiche sorti e progressive dello Stato unitario, sempre celebrato da chi a destra, a sinistra e a centro aveva sempre ritenuto che tutto si poteva criticare in Italia ma non l’Italia Unita e i suoi eroi risorgimentali.
Come spiegare diversamente –ma è solo un esempio– l’atteggiamento nei confronti di Garibaldi? Durante il ventennio fu santificato ed eletto “naturalmente” come padre putativo di Mussolini e del regime e dunque fu “fascista”. Come fu santificato il Risorgimento, cui il Fascismo si collegava strettamente perché visto “ come il periodo di maturazione del senso dello Stato”, “uno Stato forte, realtà morale, <etica> e non naturale, che <subordina a sé ogni esistenza e interesse individuale>.
Dopo il fascismo, prima nel ’48, alle elezioni politiche, la sua icona fu scelta come simbolo elettorale del Fronte popolare e dunque divenne socialcomunista. Negli anni ‘80 fu osannato da Spadolini – e dunque divenne repubblicano – “come il generale vittorioso, l‘eroico comandante, l’ammiraglio delle flotte corsare e l’interprete di un movimento di liberazione e di redenzione per i popoli oppressi”; fu celebrato da Craxi – e dunque divenne socialista – “come il difensore della libertà e dell’emancipazione sociale che univa l’amore per la nazione con l’internazionalismo in difesa di tutti i popoli e di tutte le nazioni offese”; infine fu persino rivendicato da Piccoli che lo fece dunque diventare democristiano.
Ecco è proprio questo unanimismo, questa unione sacra – destra, sinistra centro, tutti d’accordo - intorno al Risorgimento e ai suoi personaggi simbolo, che non convince; è questa intercambiabilità ideologica dei suoi “eroi” che rende sospetti. Ecco perché bisogna iniziare a fare le bucce al Risorgimento, ecco perché occorre iniziare a sottoporre a critica rigorosa e puntuale tutta la pubblicistica tradizionale – ad iniziare dunque dai testi di storia - intorno a Garibaldi, liquidando una buona volta la retorica celebrativa del Risorgimento. Per ristabilire, con un minimo di decenza un po’ di verità storica occorrerebbe infatti, messa da parte l’agiografia e l’oleografia patriottarda, andare a spulciare fatti ed episodi che hanno contrassegnato, corposamente e non episodicamente, il Risorgimento e Garibaldi: Bronte e Francavilla per esempio. Che non sono si badi bene, episodi né atipici né unici né lacerazioni fuggevoli di un processo più avanzato. Ebbene, a Bronte come a Francavilla vi fu un massacro, fu condotta una dura e spietata repressione nei confronti di contadini e artigiani, rei di aver creduto agli Editti Garibaldini del 17 Maggio e del 2 Giugno 1860 che avevano decretato la restituzione delle terre demaniali usurpate dai baroni, a chi avesse combattuto per l’Unità d’Italia. Così le carceri di Franceschiello, appena svuotate, si riempirono in breve e assai più di prima. La grande speranza meridionale ottocentesca, quella di avere da parte dei contadini una porzione di terra, fu soffocata nel sangue e nella galera. Così la loro atavica, antica e spaventosa miseria continuò. Anzi: aumentò a dismisura. I mille andarono nel Sud semplicemente per “traslocare” manu militari, il popolo meridionale, dai Borboni ai Piemontesi. Altro che liberazione!
Così l’Unità d’Italia si risolverà sostanzialmente nella “piemontesizzazione” della Penisola e fu realizzata dal Regno del Piemonte, dalla Casa Savoia, dai suoi Ministri – da Cavour in primis - dal suo esercito in combutta con gli interessi degli industriali del Nord e degli agrari del Sud - il blocco storico gramsciano – contro gli interessi del Meridione e delle Isole e a favore del Nord; contro gli interessi del del popolo, segnatamente del popolo-contadino del Sud; contro i paesi e a vantaggio delle città, contro l’agricoltura e a favore dell’industria.
C’è di più: si realizzerà un’unità biecamente centralista e accentrata, tutta giocata contro gli interessi delle periferie e delle mille città e paesi che storicamente avevano fatto la storia e la civiltà italiana. A dispetto del pensiero della gran parte degli intellettuali italiani che durante il “Risorgimento” e dopo furono federalisti e non unitaristi.
4. Gli intellettuali federalisti italiani e sardi
Di questi i libri di storia non parlano, per molti non vi è neppure un cenno: evidentemente per loro non vi è spazio, questo infatti è occupato per intero dai Cavour, Mazzini, Garibaldi. Eppure sono molti e di grande spessore culturale e politico. Un bel volumetto (1) degli storici Renzo Del Carria e Claudio de Boni documenta con puntigliosità e rigore che erano federalisti la gran parte degli intellettuali dell’Italia preunitaria (da Cattaneo a Ferrari, da Mamiani a Rosmini, da Cernuschi a Balbo e Gioberti, da Durando ad Amari, da Perez a Ferrara, da Montanelli a Busacca, da Matteucci a Busi, da Lambruschini ad Alberi e Ridolfi) come dell’Italia postunitaria (da Anelli a Bovio, da Mario a Salvemini, da Trentin ai sardi Umberto Cao, Egidio Pilia, Camillo Bellieni, Emilio Lussu). Di cui non conosciamo niente o quasi. Sono moderati altri democratici e progressisti ma tutti sono uniti da una comune analisi: la penisola italiana non era una realtà unitaria, perché dalla protostoria agli albori del Risorgimento, era stata sempre un’entità geografica e mai un’entità politica. E anche quando negli ultimi 500 anni era diventata un’entità culturale, lo era stata solo per una ristretta èlite, per la quale il toscano filtrato dallo “stil nuovo”, da Dante, Petrarca e Boccaccio, era diventata la lingua letteraria <franca>, in graduale sostituzione del precedente latino.
Ma fino agli albori del ‘700 i vari popoli della penisola italiana costituivano delle <etnie regionali> fra loro ben distinte per usi, costumi, lingue, storia e geografia. E’ questo il motivo principale che porta la gran parte degli intellettuali dell’Italia preunitaria a sposare le tesi federaliste e non quelle unitariste e centraliste, convinti com’erano che solo la forma statuale federalista avrebbe salvaguardato l’autonomia, la diversità e la particolarità di ogni etnia, oltre che la libertà di ogni singolo cittadino.
Fra i moderati, uno degli esponenti più lucidi è Cesare Balbo che scrive (2) :”La Confederazione è l’ordinamento più conforme alla natura e alla storia italiana perché la penisola raccoglie da sé, da Settentrione a Mezzodì, province e popoli quasi così diversi fra di loro, come sono i popoli settentrionali e più meridionali d’Europa, ondechè fu e sarà sempre necessario un governo distinto per ciascuna di tutte o quasi tutte queste province”. Sullo stesso versante si muove Giacomo Durando: noi siamo sette nazioni o, se si vuole, sette subnazionalità provinciane. Concentrarsi in una sola non è possibile…l’italiano insulare non è lo stesso che l’eridanio o l’apennino. Il siciliano e il sardo sono, se così posso esprimermi, di una pasta differente da quella di un lombardo”.
Sulla divisione storica si sofferma anche Terenzio Mamiani: “L’Italia è da secoli divisa e rotta in più stati e ha fra essi poca o veruna comunanza di vita politica, per la qualcosa non potendosi togliere di mezzo le divisioni e volendo pure che l’Italia sia una quanto è fattibile mai, rimane che noi ci acconciamo a quella forma di unità che sola può coesistere con la pluralità degli stati, cioè a una confederazione”.
Fra i democratici, Carlo Cattaneo insieme a Ferrari, è l’esponente che con maggiore coerenza sviluppa il suo pensiero ponendo l’accento sul nesso inscindibile fra federalismo e libertà. Così scrive: “Non potersi conservare la libertà se il popolo non vi tiene le mani sopra. Sì, ogni popolo in casa sua sotto la sicurtà e la vigilanza degli altri tutti….io credo che il principio federale, come conviene agli stati, conviene anche agli individui. Ognuno deve conservare la sua sovranità personale, ossia la sua libera espressione…la federazione è la sola unità possibile in Italia…è la pluralità dei centri viventi ed è meglio vivere amici in dieci case che vivere discordi in una sola. Dieci famiglie ben potrebbero farsi il brodo a un solo focolare, ma v’è nell’animo umano e negli affetti domestici qualche cosa che non si appaga con la nuda aritmetica e col brodo”.
Nella polemica con gli unitaristi e i centralisti insiste Giuseppe Ferrari secondo cui: “L’unità italiana non esiste se non nelle regioni della poesia e della letteratura e in queste regioni non si trovano popoli e non si può ordinare verun governo…la realtà italiana è la divisione storica degli stati, il diritto di ogni italiano è di vivere libero nei propri stati. E a ogni stato la sua assemblea, il suo governo, i suoi ministri, la sua costituzione. La rivoluzione conduce necessariamente le repubbliche a una federazione repubblicana”. E a fronte delle accuse di <divisione> Ferrari rispondeva: ”Fu sparso l’errore che la Federazione volesse dire divisione, dissociazione, separazione. Ma la parola federazione viene da foedus, vuol dire patto, unione, reciproco legame”.
Sullo stesso terreno, polemizzando con Cavour, Enrico Cernuschi afferma: “Improvvisata in Italia l’unità, col sopprimere gli stati, sopprime tutti quanti i centri di emulazione, non ne vuole che uno solo, fittizio e odiato da tutti; essa offende gli interessi, le consuetudini e i sentimenti; scompone, in una parola, tutto intero il paese senza poterlo ricomporre perché ci vuole lentezza assimilante o violenza decisa a ricomporre unpaese…la federazione invece mantiene le autonomie, lascia ogni stato padrone del proprio governo, vivifica le emulazioni, acqueta gli interessi”.
Per il sicilianoFrancesco Ferrara: ”La Sardegna è una specialità alla quale ciò che di più pernicioso può farsi è il volerla costringere ad una assimilazione completa di forme, contrastate a ogni passo dalla natura. Il Piemonte nella sua condizione di possessore di un’isola, può dirsi già fortunato dell’avere incontrato nel buon senso dei Sardi una docilità, anzi una vogliosità di fusione, che non è molto agevole rinvenire nell’indole dell’isolano; ma non ci illudiamo perciò: una nota di gratitudine, uno slancio di patriottismo non bastano a mutare il suolo, il clima, il carattere, i bisogni, le attitudini individuali e produttive, il dialetto, le conseguenze di un lungo passato.
La grande utopia del secolo è questa delle fusioni: nulla di più agevole che congiungere e assimilare in belle frasi scappate nel calore di una improvvisazione politica….ma nulla di più puerile che l’illudersi sull’effetto reale delle belle frasi. Nella natura materiale non si combinano che molecole affini. Nella natura umana, se vi ha mezzo di combinare due popoli, è quello di non sforzarne le specialità”.
Infine i federalisti sardi. Per tutti e quattro (Pilia e Cao, Lussu e Bellieni) la lotta contro il centralismo politico si traduce anche in critica del decentramento fino ad allora praticato, perché illusorio oppure limitato al solo momento amministrativo, senza respiri di politica regionale che sorgano dal basso e non siano mere concessioni alla “periferia” provenienti dall’alto.
Scrive Cao: “La compartecipazione politica della Sardegna nello stato italiano, non dovrà essere limitata all’opera insufficiente di una scarsa dozzina di emissari, ineluttabilmente destinata a disperdersi nella baraonda parlamentare, ad essere irrisa e travolta nella corrotta burocrazia della capitale e vinta dalla sopraffazione dell’affarismo politico degli industriali e degli agrari….occorrerà il ristabilimento di speciali ordinamenti regionali, consoni alla loro natura etnica e allo sviluppo secolare del loro diritto”. E tutto ciò – per Cao – sarà possibile solo “con l’annientamento dell’attuale stato sfruttatore, parassitario, apoplettico, soffocatore”.
Sostiene Pilia: ”La forma federale repubblicana apparve allora ai migliori dei nostri l’unica che potesse conciliare le esigenze della libertà e indipendenza sarda con le ragioni del movimento unitario italiano; e le pagine immortali del Tuveri e del Brusco-Onnis sono la prova di questo stato d’animo diffuso nell’Isola nei primi decenni dopo l’Unità d’Italia”
Per Bellieni il riordinamento in senso autonomistico della regione deve dar luogo all’instaurazione di uno stato federale perché “la macchina statale del presente ci soffoca e ci opprime”.
Lussu infine scrive che “Non basta più dire <autonomia> bisogna dire <federazione>. ”Il Federalismo non è certo una miracolosa <acqua di catrame> fatta per sanare tutti i mali, ma non v’è ombra di dubbio che la cosiddetta crisi della democrazia moderna, è in gran parte prodotto del centralismo statale….e il centralismo statale ha fatto fallimento nel nostro Paese”.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1)Renzo Del Carria-Claudio De Boni, “Gli Stati Uniti d’Italia” ed. D’Anna, Ancona-Mressina 1991
2) Questa citazione come tutte le altre che seguiranno sono tratte dal volume citato al punto 1di Del Carria-De Boni
5. La “nazione sarda” nella storia
a)La nazione sarda nel periodo giudicale
L’espressione “nazione sarda” comincia a ricorrere con frequenza e poi sempre più insistentemente in documenti (trattati e carte diplomatiche) che accompagnano le relazioni e i conflitti fra il Giudicato di Arborea e il regno d’Aragona (1353-1410) (1)
Ma anche prima si iniziano a cogliere alcuni elementi distintivi della Sardegna che si presenta all’Italia e all’Europa: primo fra tutti la lingua con il volgare sardo, appunto fin dal 1080-85 (nel Privilegio logudorese) e poi nei diversi Condaghi ma soprattutto nella Carta De Logu.
Il termine naciò sardesca viene usato la prima volta nel documento che sancisce l’atto di pace il 24 Gennaio 1388 fra i rappresentanti di Eleonora con gli inviati del re aragonese Giovanni i il cacciatore e sta a indicare “la Sardegna non regnicola, la parte avversa alla corona, il territorio sardo riconquistatoi dai giudici e annesso allo stato arborense. Cioè la Sardegna auctotona” (2)
L’uso del termine nazione sarda è comprovato dalle stesse carte della corona di Arborea: esso sarà alla base di quel monumento storico, giuridico e linguistico della Carta. Come sosterrà Bellieni.
La lotta sanguinosa fra naciò sardesca (o nasione sardisca) e naciò catalana non si può considerare chiusa con la battaglia di Sanluri (1409), dopo di essa infatti si continua a parlare ugualmente di nazione sarda (traditrice e ribelle secondo il re di Aragona Martino il vecchio).
Affermatosi definitivamente il dominio aragonese a seguito della sconfitta dell’ultimo marchese di Oristano Leonardo Alagon (1478) la contrapposizione fra naciò sarda e naciò catalana non scompare: è presente negli atti dei parlamenti isolani e nelle richieste avanzati da questi cioè nei Capitoli di corte che erano dei patti fra la nazione e il re (3)
b) La nazione sarda nel ‘500-‘600
L’intellighenzia isolana, dal canto suo, se una parte rimane acceccata di fronte agli splendori dell’impero spagnolo e da ascara si prostra servilmente ad esso ed evita con grande cura lo stesso termine di nazione sarda, penso allo storico Giovanni Francesco Fara (4) che usa il termine natio (scrive in latino) per indicare di “nascita”, il poeta ecclesiastico Gerolamo Araolla (5) (1545-fine secolo XVI), alle lingue castigliana e catalana contrappose una lingua sarda che potesse vantare una sua dignità sul piano letterario. Non è questa la sede per verificare i risultati del tentativo di Araolla: certo è che in lui si inizia a delineare un embrionale coscienza del rapporto fra nazione e lingua.
Che sarà ancor più forte nello scrittore Gian Matteo Garipa, orgolese (?-1640)
che scriverà « Totas sas nationes iscrien & istampan libros in sas proprias limbas naturales insoro…disijande eduncas eo ponner in platica s’iscrier in sardu pro utile de sos qui non sun platicos in ateras limbas, presento assos sardos compatriotas mios custu libru »(6).
Invito a notare i termini, estremamente chiari e significativi: parla di lingua naturale –oggi diremmo materna- che tutte le nazioni, compresa la sarda, hanno il diritto-dovere di utilizzare per rivolgersi ai “compatrioti”, ovvero ai sardi, abitanti dunque della stessa “patria”.
c) La nazione sarda nel ‘700-‘800
Ma è soprattutto nel vivo dello scontro politico e sociale che – a parere di Federico Francioni, storico sassarese (7)- prende sempre più corpo l’idea di nazione sarda. E cita il triennio rivoluzionario 1793-1796 che vedrà protagonista principale Giovanni Maria Angioy. I Sardi, prendono coscienza di sé e del proprio essere “popolo” e “nazione” prima quando si battono con successo contro l’invasione francese poi quando cacciano i piemontesi da Cagliari con il “Vespro Sardo” del 28 Aprile 1794. Al di là delle cause che stanno alla base di questo evento –scrive ancora Francioni (8) e della stessa dinamica di quelle giornate, fu indubbiamente l’esasperazione dell’atteggiamento colonialistico, quasi razzista dei ministri regi (ampiamente documentato da uno storico in questo verso insospettabile come il Manno) la classica goccia che fece traboccare il vaso.
Il senso di appartenenza identitaria e di “nazione sarda” sarà fortemente presente nella stampa e negli scritti di quel periodo di grandi cambiamenti. <Gli ordini del regno sono depositari fedeli della sorte di tutta la nazione> si afferma nel “Giornale di Sardegna” un foglio periodico organo ed espressione del gruppo più dinamico e politicamente più progressivo degli Stamenti sardi. Ancor più forte sarà il sentimento di “popolo sardo” e di “comunità nazionale” nell’Inno di Francesco Ignazio Mannu “Su patriottu sardu a sos feudatarios”; ”nell’Achille della sarda liberazione”; nella lettera “Sentimenti del vero patriota sardo che non adula” in cui l’istanza dell’abolizione del giogo feudale si coniuga con un atteggiamento anticoloniale e un sentimento nazionale sardo.
Ancor più chiaramente tale “Identità sarda” emerge nel Memoriale al Direttorio di Giovanni Maria Angioy (Agosto 1799) in cui l’Alternos (9)cerca di cogliere e di interpretare i tratti distintivi, peculiari e originali della individualità sarda, cominciando dal quadro geografico e morfologico, proseguendo con cenni sugli usi, i costumi, le tradizioni, i rapporti comunitari, l’atteggiamento dei sardi verso gli stranieri fino a quello che si potrebbe chiamare un abbozzo “del carattere nazionale”isolano. In queste pagine non c’è solo il risentimento anticoloniale o il rimpianto per gli antichi diritti e i privilegi acquisiti dalla Sardegna nel corso dei secoli: il punto di approdo dell’esperienza e della riflessione angioyna nell’esilio parigino è ormai una repubblica sarda sia pure (come del resto era inevitabile) sotto il protettorato della Grande Nation.
Nel solco tracciato da Angioy si muoveranno Matteo Simon che individua le linee di un carattere nazionale sardo più esteso e articolato ma soprattutto consapevole del legame fra nazione e lingua e Francesco Sanna Corda, parroco di Terralba che a nome del popolo e della sarda nazione tenterà una sfortunata spedizione in Gallura nel 1802.
Di carattere nazionale dei sardi parlerà il Tola, nello scritto giovanile omonimo rimasto incompiuto; di sardo dialetto parlerà lo Spano.
d) La nazione sarda dopo la fusione perfetta e l’unità d’Italia.
E in genere fino al 1847 nessuno dubita che la Sardegna sia una nazione: da Carlo Alberto al viceré De Launay, agli storici sardi che lo ribadiscono a chiare lettere: il quadro comincia a cambiare dopo la “perfetta fusione” : l’idea di nazione sarda è del tutto assente in Asproni e Tuveri, per Mazzini addirittura l’isola è italianissima!
6. Autonomia, e Federalismo in Lussu
Afferma in un Saggio del 1933 Emilio Lussu (1):”Frequentemente accade di parlare con uno che riteniamo federalista perché si professa autonomista e scopriamo invece, che è unitario con tendenze al decentramento. L’autonomia concepita come decentramento non è più autonomia. Gli autonomisti della Sardegna si chiamavano autonomisti perché per autonomia intendevano dire federalismo, non già decentramento. D’ora innanzi adoperando la terminologia <Federalismo> non ci saranno più equivoci”. E precisa: ”Ora la differenza essenziale fra decentramento e federalismo consiste nel fatto che per il primo la sovranità è unica ed è posta negli organi centrali dello Stato ed è delegata quando è esercitata dalla periferia; per l’altro è invece divisa fra Stato federale e Stati particolari e ognuno la esercita di pieno diritto”.
Lussu esprime in questo passo, modernamente, con precisione e lucidità - e ancora oggi di grande attualità –la discriminante vera fra autonomia/decentramento e federalismo. E quando afferma che per fare chiarezza politica “non basta più dire <autonomia> bisogna dire <federazione>” non lo sostiene per una questione lessicale e terminologica ma di sostanza.
La visione autonomistica – e regionalistica, aggiungo io – dello Stato è ancora tutta dentro l’ottica dello stato unitario, indivisibile e centralista, che al massimo può dislocare territorialmente spezzoni di potere dal “centro” alla “periferia”. O, più semplicemente può prevedere il decentramento amministrativo e concedere deleghe limitare e parziali alla Regione che comunque in questo modo continua ad esercitare una funzione di “scarico”, continuando ad essere utilizzata come un terminale di politiche, sostanzialmente decise e gestite dal potere centrale.
Quando Lussa parla di sovranità “divisa” fra Stato federale e Stati particolari – o federati aggiungo io – di “frazionamento della sovranità”, pensa quindi alla rottura e alla disarticolazione dello stato unitario “nazionale” che deve dar luogo a una forma nuova di Stato di Stati, in cui “per Stati non si intendono più gli Stati nazionali degradati da Enti sovrani a parti di uno stato più grande, ma parte o territori dello stato grande elevati al rango di stati membri”(2)
In questo modo il potere sovrano originario e non derivato spetta a più Enti, a più Stati e perciò scompare la sovranità di un unico centro – che Lussu critica in quanto “unica e assorbente”(3) – di un unico potere e soggetto singolare per fare capo a più soggetti e poteri plurali.
Con questa impostazione Lussu supera il concetto di unipolarità con cui si indica la dottrina ottocentesca in cui libertà e diritto fondano la loro legittimità solo in quanto riconducibili alla fonte statale.
Ma Lussu non si limita a disegnare in astratto il futuro stato federale, gli stati membri e le rispettive competenze, egli infatti individua con precisione e nettezza anche l’ente, il soggetto che dovrà costituire lo stato membro o federato: la regione.
Così argomenta: ”La regione in Italia è una unità morale, etnica, linguistica e sociale, la più adatta a diventare unità politica. La provincia al contrario non è che una superficiale e forzata costruzione burocratica. La provincia può sparire com’è venuta, in un sol giorno, la regione rimane. La terra, il clima, le acque, la posizione geografica, antiche influenze commerciali, rapporti e attitudini particolarmente sviluppati da tempo, contribuiscono a dare a ogni regione una sua economia caratteristica e quindi una vita sociale chiaramente distinta”.
Ho voluto citare testualmente questo passo – tratto ancora una volta da <Federalismo> – per dimostrare che non solo per Lussu il futuro stato federato dovrà identificarsi con la regione ma che fonda il suo federalismo sulla identità etno-linguistica. Vi è di più :descrivendo la regione Lussu ci dà –al di la delle sue intenzioni– un ritratto compiuto della “nazione”, modernamente intesa e da non identificare con lo stato; identificazione operata invece dalla cultura ottocentesca, che purtroppo permane ancora e che permeava profondamente la visione di Lussu tanto da indurlo a parlare di “nazione mancata”, intendendo a mio parere “stato mancato”.
Il ritratto che Lussu delinea della regione si attaglia in modo particolare alla Sardegna che “deve essere nello stato italiano all’incirca quello che è il cantone nella confederazione svizzera e il land nella repubblica federale tedesca”.
Quanto alla questione del nome delle entità che dovrebbero costituire lo stato federale: regioni, repubbliche, stati federati, territori autonomi, Lussu non ha dubbi: avrebbero dovuto chiamarsi <repubbliche federate>
A chi obiettava che per diventare <stato> le nostre regioni sarebbero troppo piccole rispondeva:”Lo sarebbero come stati indipendenti, non lo sono come stati federati” E aggiunge:”Nella confederazione svizzera non vi è un solo cantone più grande delle più piccole delle regioni italiane”.
Non era quindi il criterio del territorio – secondo Lussu – ad impedire a una regione di essere l’unità di base di uno stato federale. Inoltre l’autore di “Un anno sull’altipiano” ricordava a questo proposito che nulla vietava a due o più regioni che avessero interessi comuni o unità di vita economica di unirsi in un solo stato federale.
Non è invece d’accordo con l’artificiosa divisione territoriale in quattro repubbliche federate, presentata allora – siamo nel 1933 – dal Partito comunista. Così Lussu argomenta:”Repubblica sarda e repubblica siciliana sta bene, ma il resto? Si può dividere l’Italia continentale nettamente in due sole parti, Nord e Sud? E dove finisce il Nord e incomincia il Sud?”
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1) Emilio Lussu, “ Rivista Giustizia e liberta”, n.6 de 1933
2) Norberto Bobbio “Federalismo, Introduzione a Silvio Trentin”.
3) Questa citazione come tutte le altre che seguiranno sono tratte da “Giustizia e libertà” (Vedi punto 1)
7.L’indipendenza per Antonio Simon Mossa. Importanza della Lingua sarda
Il vizio di Onesicrito.
Un certo Onesicrito tra il 332 e il 336 a.c. aveva visitato l’India al seguito di Alessandro Magno, riportandone descrizioni alquanto fantasiose, che misero lungo fuori strada i geografi dell’epoca.
Partiti, Sindacati e buona parte degli studiosi e degli storici – segnatamente quelli di impronta più statalista – per decenni ci hanno dato della “Questione sarda” una descrizione alquanto “fantasiosa”,- un po’ come Onesicrito aveva dato dell’India - riducendola a un semplice frammento o appendice della “Questione meridionale”. O in ogni caso in questa affogandola.
C’è di più: è stata considerata – come del resto l’intera Questione Meridionale - esclusivamente dal punto di vista economico ed economicistico. Non solo: ad iniziare dall’analisi gramsciana si è considerato il Sud “sottosviluppato” perché atavicamente arretrato, semifeudale, ancora precapitalistico. Tale tesi si rifaceva a Federico Engels che in una celebre lettera a Filippo Turati sosteneva appunto che il Mezzogiorno d’Italia soffriva per la mancanza di uno sviluppo capitalistico e di una rivoluzione borghese.(1)
La cartina di tornasole di questa visione della “Questione sarda” è rappresentata persino dallo Statuto speciale di Autonomia della Sardegna, tutto giocato sul crinale economicistico. Infatti – come ho già avuto modo di sostenere in un mio recente saggio su “Statuto sardo e dintorni” Artigianarte editrice, Cagliari 2001 – l’insieme degli aspetti etnoculturali e linguistici è del tutto assente, nonostante gli avvertimenti di Lussu sulla necessità di sancire l’obbligo dell’insegnamento della Lingua sarda nelle scuole in quanto “essa è un patrimonio millenario che occorre conservare" e nonostante i consigli di Giovanni Lilliu che suggeriva ai Costituenti sardi di rivendicare per la Sardegna competenze primarie ed esclusive almeno per quanto riguardava i "Beni culturali”.
Antonio Simon Mossa:la sua figura.
Non cade nel vizio di Onesicrito Antonio Simon Mossa: a proposito dello Statuto sardo ritiene per intanto che il suo difetto sostanziale stava proprio nel mancato riconoscimento del fatto che la Sardegna costituiva una “unità o comunità etnica ben distinta dalle altre componenti dello Stato Italiano”Simon Mossa è un architetto di talento, arredatore, urbanista e artista di genio, insegnante dell’istituto d’arte e scenografo, intellettuale dagli interessi pressochè enciclopedici e dalla forte sensibilità artistica, umanista e nel contempo eclettico da uomo del ‘700, viaggiatore colto e curioso del nuovo e del diverso tanto da spaziare con gusto e competenza nell’ambito di una pluralità vastissima di arti: dalla letteratura alla pittura e alle arti popolari. Ma soprattutto, - almeno per quanto mi interessa in questa sede - brillante ideologo e giornalista, polemista ironico e versatile.
Non cade - ripeto – nel vizio di Onesicrito e considera anzi la Sardegna come una colonia interna dello Stato Italiano e nel contempo una Nazione oppressa dallo stesso Stato, brutalmente e pervicacemente unitario, accentrato e centralistico
La Sardegna “colonia”
In sintonia con i “Nuovi meridionalisti”, - penso in modo particolare a Nicola Zitara (2) a EdmondoMaria Capecelatro e Antonio Carlo (3), quest’ultimo fra l’altro per molti anni docente incaricato di diritto del lavoro all’Università di Cagliari – ritiene che la Sardegna sia una “colonia interna” dello Stato italiano e che dunque la dialettica sviluppo-sottosviluppo si sia instaurata soprattutto nell’ambito di uno spazio economico unitario – quindi a unità d’Italia compiuta – dominato dalle leggi del capitale.
Simon è ugualmente in sintonia con studiosi terzomondisti come V. Baran (4) e Gunter Frank (5) che in una serie di studi sullo sviluppo del capitalismo tendono a porre in rilievo come la dialettica sviluppo-sottosviluppo non si instauri fra due realtà estranee o anche genericamente collegate, ma presuma uno spazio economico unitario in cui lo sviluppo è il rovescio del sottosviluppo che gli è funzionale: in altri termini lo sviluppo di una parte è tutto giocato sul sottosviluppo dell’altra e viceversa.
“ L’oppressione coloniale – scrive – si è intensificata con lo Stato Italiano… l’emigrazione, la distruzione dell’economia locale, l’imposizione di modelli di sviluppo forestieri comportano effetti devastanti contro la struttura sociale del popolo sardo” (6). Attacca poi duramente “l’albagia dei colonialisti romani”(7) che si permette di considerarci “straccioni, infingardi, banditi, mantenuti e queruli mendicanti”(8). Altrettanto duro è con i Partiti italiani che “rappresentavano e servivano esclusivamente gli interessi della potenza coloniale che sfruttava la Sardegna” (9). E ancora “La partitocrazia di importazione, aspetto non secondario del fenomeno di colonizzazione e di snazionalizzazione adottato dall’Italia, nella sua funzione di potenza occupante, costituisce nella nostra terra un’etichetta esteriore, uno strumento per assicurarsi il potere a tempo indefinito della madrepatria sulla colonia” (10).
Certo – scrive Simon Mossa – “ apparentemente lo Stato è democratico ma sostanzialmente colonialista…la potenza coloniale opprime da tanto tempo la nostra gente” (11). “Uno Stato di fatto prettamente coloniale” (12) che “con i suoi organi costituzionali e di sottogoverno persistono in una politica liberticida e soffocatrice per i Sardi” (13).
Riprendendo un articolo di Michelangelo Pira, apparso sulla Nuova Sardegna nell’Agosto del 1967 e condividendolo, lo cita testualmente:” La Sardegna ha sperimentato non solo la politica coloniale ma anche quella di colonizzazione in senso stretto. Ieri le migliori località della costa sarda erano occupati dai miliardari, oggi dal capitale forestiero industriale turistico. Ieri Arborea, oggi i poli industriali. La politica italiana è sempre stata politica colonialista, sia quando si è rivolta all’esterno con le avventure africane, sia quando si è rivolta all’interno. Sono cambiati i miti di questa politica ma la sostanza è rimasta. Che oggi siano i tecnocrati di Roma o di Bruxelles a dire quel che è bene fare o non fare in Baronia e dintorni anziché i ministri piemontesi, non cambia molto, cioè non rovescia la tendenza. Mutano le forme del colonialismo ma la sostanza politica di sfruttamento delle zone coloniali, resta” (14).
La Sardegna “nazione oppressa”.
Oltre che colonia interna, per Simon Mossa la Sardegna è una “nazione oppressa”, “proibita”, “non riconosciuta” dallo Stato Italiano, emarginata dalla storia, insieme a tutte le altre minoranze etniche del mondo. In Europa al pari dei Baschi, Catalani, Bretoni, Occitani, Irlandesi etc. Contro cui è in atto un pericolosissimo processo di “genocidio” soprattutto culturale ma anche politico e sociale. Si tratta di “minoranze” che “l’mperiale geometria delle capitali europee vorrebbe ammutolire” (15).
Per Simon Mossa, che la Sardegna abbia una sua precisa identità etno-nazionale è indubitabile, tanto da portarlo a polemizzare duramente con chi la nega:” Non crediamo certo – scrive – allo slogan “Sardegna nazione mancata” coniato dai rinunciatari di ogni tempo e di ogni colore” (16).
Più precisamente cosi definisce la Sardegna “Noi Sardi costituiamo una comunità etnica abbastanza omogenea e compatta” (17). Lo stesso concetto ripete sia al Convegno di San Basilio a Ollolai il 22 Giugno 1969 sostenendo che la Sardegna è “Una Comunità etnica con i suoi aspetti storici, geografici, sociali, economici e culturali (Lingua, tradizioni popolari etc.)(18); sia parlando con l’Europeista Guy Heurod a Strasburgo, nell’Ottobre dello stesso anno quando afferma “ Noi concepiamo la regione come entità umana, economica, in una parola etnica”(19).
Del resto – sostiene Simon Mossa – “Persino lo Stato ha riconosciuto, almeno formalmente una sostanziale differenza fra la Sardegna e le Regioni interne del Paese. Cioè ha implicitamente riconosciuto la Comunità etnica o il popolo sardo che dir si voglia, tale da essere degno di un vero e proprio autogoverno…di un riconosciuto diritto storico” (20). E ancora, sempre sulla stessa lunghezza d’onda, ma polemizzando sommessamente con i Sardi un po’ autocolonialisti e un po’ ascari scrive :” Gli stessi italiani più realistici e politicamente ben più avanzati dei Sardi, avevano nella loro Costituzione Repubblicana solennemente confermato il diritto della Sardegna a uno Statuto speciale, cioè gli Italiani riconoscevano in sede costituzionale il carattere di <comunità distinta> al popolo sardo per le ragioni storiche, geografiche etniche, sociali che il Partito sardo aveva con chiarezza sin dalle origini posto sul tappeto” (21).
“Il Genocidio”.
Per annichilire e distruggere l’identità etno-nazionale dei Sardi è in atto – secondo Simon Mossa – “un processo forzato di integrazione che minaccia l’identità culturale, linguistica ed etnica” (22).
Una vera e propria aggressione, un “genocidio” sia pure “sotto ad innocente maschera della difesa di determinati interessi di classe o di casta, di privilegi, di antiche sopraffazioni”(23).
E’ lo stesso processo di “snazionalizzazione” delle minoranze etniche che vivono in Europa. “Secondo gli studi di investigatori dell’Unesco si sta arrivando – scrive Simon – a una vera e propria azione di <genocidio>. Cioè alla snazionalizzazione ad oltranza, da parte di tutte le nazioni europee verso le minoranze e le comunità etniche comprese nel proprio territorio….l’Italia che pure aderisce all’Unesco non ha mai e poi mai ottemperato alle stesse norme e gli accordi internazionali. I gravi problemi economici hanno sempre posto nella Repubblica in secondo piano i problemi delle minoranze e delle comunità etniche. L’operazione <genocidio> viene applicata egualmente in Italia con i guanti di velluto anziché col bastone” (24).
Complici di tale <genocidio> sono anche i Sardi:” Oggi troppi sardi si lasciano comprare e si applicano con spietata brutale complicità all’opera di genocidio che si sta attuando” (25).
E si commette genocidio “ Non solo distruggendo fisicamente un popolo. Vi sono altri modi: assoggettandolo a schiavitù e a regime coloniale, assimilandolo per mezzo dell’integrazione: questo è il più moderno, il più subdolo perché incomincia con l’intorpidimento delle coscienze, ma il punto di arrivo è lo stesso: l’uccisione della coscienza comunitaria di un popolo e la distruzione della sua personalità”(26).
Antonio Simon Mossa, dotto in lingue diverse, viaggiatore colto e aperto alle problematiche delle minoranze etniche mondiali, ma soprattutto europee, che conosce direttamente, “de visu”, si rende conto della drammatica minaccia di estinzione che pesa su di loro: oramai sul bilico della scomparsa. Si tratta di una vera e propria catastrofe antropologica che qualche anno dopo, rispetto all’analisi e alle previsioni di Simon Mossa, sarà impietosamente documentata dal noto Centro Studi di Milano “Luigi Negro”, secondo il quale ormai ogni anno scompaiono nel mondo dieci minoranze etniche e con esse altrettante lingue, modi di vivere originali, specifici e irrepetibili, culture e civiltà. Il pretesto e l’alibi di tale genocidio è stato ed è che occorreva e che occorre superare, trascendere e travolgere le arretratezze del mondo “barbarico”, le sue superstizioni, le sue aberranti credenze, i suoi vecchi e obsoleti modelli socio-economico-culturali: espressioni di una civiltà preindustriale ormai tramontata.
I motivi veri sono invece da individuare nella tendenza del capitalismo e degli Stati – e quindi delle etnie dominanti – a omologare e assimilare, in nome di una falsa unità, della razionalità tecnocratica e modernizzante, dell’universalità cosmopolita e scientifica, le etnie minori e marginali e con esse le differenze e specificità, in quanto “altre”, scomode e renitenti.
Quella ”unità” di cui parla lo scrittore Eliseo Spiga in un suo recente suggestivo e potente romanzo "Capezzoli di pietra": “Ormai il mondo era uno. Il mondo degli incubi di Caligola. Un’idea. Una legge. Una lingua. Un’eresia abrasa. Un’umanità indistinta. Una coscienza frollata. Un nuragico bruciato. Un barbaricino atrofizzato. Un’atmosfera lattea. Una natura atterrita. Un paesaggio spianato. Una luce fredda. Città villaggi campagne altipiani livellati ai miti e agli umori di cosmopolis”. Che vorrebbe – aggiungo io - un mondo uniforme, una sfera rigida e astratta nell’empireo e non invece tanti mondi, ciascuno col proprio movimento e con un suo essere particolare e inconfondibile.
Dentro l’ottica unitarista e globalizzante, le lingue delle minoranze vengono degradate, represse e tagliate, in ossequio alle lingue di Stato, imperanti e imperiali, omologanti e impoverenti, anche perché loro stesse sono ormai giunte all’afasia quasi totale: in questo modo, insieme alle lingue minori vengono distrutti e saccheggiati interi patrimoni culturali fatti di espressività popolare, di codici etici, religiosi e giuridici, di memoria e vissuto storico, di tesori artistici e ambientali.
Simon Mossa aveva visto con i suoi occhi e in luoghi diversi tutto ciò: terribile e insieme profondo. Aveva cioè verificato la tendenza del genocidio culturale e non solo, dei piccoli popoli, delle piccole patrie, incorporate e chiuse coattivamente nei grandi leviatani europei e mondiali, “entro un sistema artificioso di frontiere statali, sottoposti a controllo permanente, con evidenti fini di spersonalizzazione, ridotti all’impotenza e di continuo minacciati delle più feroci rappresaglie se mai tentassero di rompere o indebolire la sacra unità della Patria” (27).
Anche quando non si trattava di una vera e propria guerra, l’emigrazione di massa, il tentativo di liquidare e potare le culture e le lingue auctotone, di distruggere le attività economiche locali imponendo modelli di sviluppo estranei quando non ostili alle vocazioni naturali del territorio, portava inesorabilmente verso la distruzione etnica.
Finalità e obiettivi di Simon Mossa
Questo fenomeno per l’architetto algherese avanzava anche in Sardegna: di qui le sue proposte e la sua militanza politica per bloccarlo. Egli infatti non è solo un brillante ideologo ma un leader di lotte e di iniziative, politiche e culturali concrete. E’ anzi difficile trovare – come in lui – così miracolosamente fuso il nesso teoria-prassi. E la sua azione teneva sempre conto di tutte le componenti della “Questione sarda”: da quelle economiche e sociali a quelle politiche, storiche, culturali, linguistiche ed artistiche, convinto com’era che la soluzione della “Questione sarda” doveva aggredire tutti questi nodi e dunque non limitarsi al versante esclusivamente economico. “ Il nostro obiettivo – scrive – è la liberazione della Sardegna dal giogo coloniale, la redenzione sociale del nostro popolo….Lo Stato italiano ha dimostrato e dimostra di essere ferocemente colonialista e liberticida nei nostri riguardi…noi vogliamo conquistare l’indipendenza per integrarci non per separarci nel mondo moderno. Noi siamo nella stessa posizioni di quei paesi del Terzo Mondo che, nelle loro articolazioni nazionali, hanno già compiuto i primi passi verso l’indipendenza”(28).
In questo passo è delineato con nettezza l’obiettivo simoniano: rompere la dipendenza coloniale – e dunque lo sfruttamento economico – e nel contempo liberare i sardi dall’oppressione nazionale. Il tutto dentro una cornice europea e mondiale.
Simon Mossa, algherese di famiglia, membro dunque di una minoranza (quella catalana) dentro una minoranza (quella sarda) non perde dunque mai di vista nelle sue analisi come nelle sue azioni, le numerose altre nazionalità europee ed extraeuropee, al pari di quella sarda soggette a una duplice oppressione, quella “coloniale” e quella “nazionale”. Anzi, alle minoranze del “Terzo mondo europeo” propone una Federazione: sposta così la prospettiva federalista dal terreno italiano a quello euromediterraneo. Non solo. Ribaltando la visione tradizionale del federalismo europeo, all’Europa degli Stati contrappone l’Europa delle Regioni etniche e autonome, delle comunità minoritarie, delle piccole nazionalità, ignorate, contrastate e oppresse che “avrebbero provocato un radicale mutamento degli stessi confini tradizionali degli Stati” (29).
Di qui il suo impegno perché tra le comunità etniche europee e la comunità sarda ci fossero scambi permanenti e lavora dunque per un processo di organiche alleanze anche “per evitare la dispersione del ricco patrimonio culturale europeo costituito dalle lingue regionali e dai dialetti, dalle cosiddette lingue mozze”(30): quest’ultima frase virgolettata è dello scrittore italiano Gaspare Barbiellini Amidei, ma sicuramente Simon Mossa l’avrebbe sottoscritta. E avrebbe condiviso in toto quanto Barbiellini sostiene in un suggestivo saggio, (“Il Minusvalore”, Rizzoli ed.,Milano 1972): gli uomini ricchi – ed io aggiungo i popoli ricchi – rubano da sempre agli uomini poveri,
-ed io aggiungo ai popoli poveri – la loro fatica, pagandola con un salario che è soltanto una parte dei loro prodotti. Il resto, plus valore, va ad accumulare altra ricchezza. Ma gli uomini – e i popoli – ricchi rubano agli uomini – e ai popoli – poveri anche la memoria, la lingua, la cultura, la bontà.
Identità, Lingua e cultura
Uno degli elementi che per Simon Mossa devasta maggiormente l’Identità di un popolo è l’attacco alla cultura e alla lingua locale: in Sardegna dunque il divieto e la proibizione della cultura e della lingua sarda, segnatamente dell’uso pubblico del Sardo.
L’ideologo nazionalitario e indipendentista, poliglotta – conosce infatti e parla correttamente lo spagnolo, il catalano, l’inglese, il tedesco, oltre che il Sardo in tutte le sue sfumature, ma studia anche il russo, il greco e l’arabo – sa bene che un popolo senza Identità, in specie culturale e linguistica, è destinato a “morire”: “ Se saremmo assorbiti e inglobati nell’etnia dominante e non potremmo salvare la nostra lingua, usi costumi e tradizioni e con essi la nostra civiltà, saremmo inesorabilmente assorbiti e integrati nella cultura italiana e non esisteremo più come popolo sardo. Non avremmo più nulla da dare, più niente da ricevere. Né come individui né tanto meno come comunità sentiremo il legame struggente e profondo con la nostra origine ed allora veramente per la nostra terra non vi sarà più salvezza. Senza Sardi non si fa la Sardegna. I fenomeni di lacerazione del tessuto sociale sardo potranno così continuare, senza resistenza da parte dei Sardi, che come tali, più non esisteranno e così si continuerà con l’alienazione etnica, lo spopolamento, l’emarginazione economica. Ma questo discorso è valido nella misura in cui lo fanno proprio tutti i popoli parlanti una propria originale lingua e stanzianti in un territorio omogeneo, costituenti insomma una nazione che sia assoggettata e inglobata in uno Stato nel quale l’etnia dominante parli una lingua diversa” (31).
A fronte di questo pericolo e di questo rischio reale, documentato fra l’altro dal fatto che i Sardi stanno abbandonando uno dei tratti più significativi ed essenziali della loro Identità, ovvero la propria lingua materna, Simon Mossa interviene su questo versante come su quello complessivo della Sardità e dunque dell’etnos, con i suoi scritti come con la sua iniziativa politica concreta: dalla battaglia per difendere l’autonomia di Radio Sardegna – la radio perderebbe immediatamente le sue capacità educative , scriveva ne <Il Solco letterario> del 23 Settembre 1965, se dovesse essere accentrata, unitaria e controllata da un gruppo o da una fazione politica - ai modi auctotoni di costruzioni, alieno com’era dal seguire schemi e mode esterne.
Ha scritto Vico Mossa:” Doveva trasparire la sardità quando fu incaricato di ampliare e modificare il primo Piccolo Hotel El Faro, presso la Torre di Porto Conte, ispirandosi a partiti costruttivi delle <lolle di Assemini>…Sortì un effetto razionale ed accogliente, che piacque agli ospiti del primo vero boom turistico di Alghero: era un albergo che si attagliava alla cittadina catalana” (32).
Sempre a proposito della sua architettura ha scritto G. B. Melis” Le sue soluzioni erano ispirate dall’arte e interpretate con senso di poesia e di genuina fedeltà alla matrice: la Sardegna, il suo mondo, valorizzato e fuso nelle realizzazioni più rispondenti alle tecniche più moderne e razionali”(33).
La sua attività di costruzione-ricostruzione dell’Identità etnonazionale dei Sardi vista in tutte le sue componenti – abbiamo già accennato a quella architettonica e artistica - è particolarmente intensa nello studio e nella valorizzazione del Sardo come del Catalano di Alghero.
Appassionato e studioso di lingua e di linguistica - fra l’altro traduce in Sardo il Vangelo e scrive ottave deliziose – ritiene che “Il sardo lungi dall’essere un dialetto ridicolo è già, ma in ogni modo può e deve essere una lingua nella misura in cui sia parlato e scritto da un popolo libero e capace di riaffermare la propria identità”(34). A questo proposito pone questo interrogativo “ Hai mai meditato su ciò che significa l’esclusione della nostra lingua madre dalle materie di insegnamento delle scuole pubbliche e il divieto di farne uso negli atti “ufficiali”? Ci regalano insegnanti di un italiano spesso approssimativo e zeppo di provincialismo e noi non abbiamo il diritto di esprimerci adeguatamente nella nostra lingua! Ci hanno privato del primordiale e più autenticamente <autonomista> strumento di comunicazione fra gli uomini!” (35)
Sostiene ciò nel Luglio del 1967 al Convegno- di “Studi dottrinari sardisti” a Bosa, molto prima che in Sardegna la Questione del “Bilinguismo perfetto” diventasse oggetto di discussione prima e di iniziativa politica poi: a buona ragione possiamo perciò considerare Simon Mossa il precursore più avveduto, il vero profeta e anticipatore delle proposte prima e della Legge sul Bilinguismo poi. Con acume e perspicacia aveva capito che il problema della Lingua sarda non era tanto o soltanto parlarla, magari nell'ambito familiare, ma scriverla e soprattutto insegnarla nelle Scuole e usarla nella Pubblica Amministrazione: il problema era cioè la sua ufficializzazione.
Oggi noi nel 2002 sappiamo bene che la Lingua sarda, al di fuori di questa prospettiva è destinata a morire o, al massimo, a vivacchiare e languire, marginalizzata e ghettizzata nei bomborimbò delle feste paesane. Simon Mossa questo lo aveva capito ben più di 30 anni fa: di qui la sua azione.
Nel 1960 pubblica il periodico “Reinaixencia nova” scritto completamente in catalano. Il 10 Settembre 1961 organizza con il Centro d’Estudios Algheresos – di cui è Presidente – “Giochi floreali della lingua catalana” ad Alghero; nello stesso periodo promuove una “Sezione per la poesia algherese” all’interno del “Premio Ozieri” (36) a cui peraltro aveva segretamente concorso nello stesso 1961 con una poesia in sardo (titolo: ”Cabras”) ottenendo il sesto premio e la menzione speciale d’onore, prima che nell’anno successivo entrasse nella Giuria stessa del premio.
La valorizzazione delle tradizioni popolari come delle gare poetiche per Simon Mossa non è vista però come mania estetizzante e folclorica ma come sforzo – uso volutamente una bella espressione di Antonello Satta - “per tentare di non far inaridire le radici culturali intime della nostra sfiorita nazionalità” (37). E sa limba è per Simon Mossa lo strumento fondamentale: per combattere “l’integrazione e l’oppressione unitarista statuale“ (38); per opporsi “al massiccio attacco in atto dell’imperialismo delle <culture superiori> e delle maggiori comunità etniche nazionali”(39); “|per la rivoluzione sarda per l’indipendenza, non tanto e non solo di emancipazione e economica e sociale ma anche e soprattutto di libertà dell’intero popolo in senso etnico, etico e culturale”(40).
Per Antonio Simon Mossa il problema dell’autonomia culturale del popolo sardo fu dunque quello centrale in tutto il suo pensiero e in tutta la sua appassionata azione politica. Per questo la questione della Lingua sarda, ovvero “della possibilità di scambio, di informazione e di istruzione nell’ambito della comunità, senza la presenza del dominatore e senza la sua tutela, aveva per lui tanto rilievo” (41). Egli infatti vedeva la difesa e lo sviluppo dell’autonomia culturale, non tanto – o non solo – come la riscoperta o il recupero, in qualche modo etnografico e antropologico, degli antichi valori e degli istituti giuridici, etici, consuetudinari o come la cernita minuta di quanto sia vivo e di quanto sia morto nel magma della tradizione isolana; bensì come ricerca proiettata nel futuro, dell’identità nazionale dei Sardi. E ricerca “non puramente storica e letteraria, ma come resistenza e lotta popolare contro l’asfissia e il livellamento culturale perpetrati dal capitalismo e dall’imperialismo. Non gli era sfuggito che quindi senza la riaffermazione dell’autonomia culturale, anche la più gloriosa lotta di liberazione popolare può approdare a risultati solo parziali e precari” (42).
Conclusione
Da più parti si è parlato di Antonio Simon Mossa come di un vecchio cavaliere ed eroe romantico, di un apostolo, di un nuovo profeta, idealista e utopista. Può darsi. Forse era anche “irragionevole”. Ma di quella irragionevolezza di cui parlava un caustico esponente della cultura europea del primo Novecento quando affermava che l’uomo ragionevole si adatta al mondo, l’uomo irragionevole vorrebbe adattare il mondo a se stesso: per questo ogni progresso dipende dagli uomini irragionevoli.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Marx-Engels, “Corrispondenze con Italiani” Milano 1864.
2. Nicola Zirara, “L’Unità d’Italia- nascita di una colonia”, ed. Jaca-Book,
Milano, 1971.
E. M. Capecelatro- A. Carlo, “Contro la Questione Meridionale”, ed.
Savelli, Roma 1972.
3. V. Baran, “Il surplus economico e la teoria marxiana dello sviluppo”,
Milano,1966
5. Gunter Frank, “Capitalismo e sottosviluppo in America latina, Torino 1969
6. Relazione in ciclostilato nella Riunione di Ollolai (10 Giugno 1967) nei monti del Santuario di Santu Basili, ora in “Antonio Simon Mossa: Le ragioni dell’indipendentismo” Ed. S’Iscola Sarda. Sassari 1984 a cura di Cambule-Giagheddu-Marras e in “Sardisti” vol.II di Salvatore Cubeddu, Ed. EDES, Sassari 1995, pagg.476-477.
7. La Nuova Sardegna 4 Agosto 1967:”No ai Sardi straccioni” di Fidel.( Lo pseudonimo con cui Antonio Simon Mossa firmava, per la gran parte, i suoi articoli: Altri pseudonimi cui ricorse furono: “Giamburrasca”, “Il Moro”, “Cecil”.
8. Ibidem.
9. Tesi di F. Riggio, Etnia e Federalismo in Antonio Mossa, relatore il Prof. Giancarlo Sorgia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari, A.A. 1975-76.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. La Nuova Sardegna 1° Agosto 1967.
13. Ibidem.
14. La Nuova Sardegna, Agosto 1967, Intervento di Michelangelo Pira.
15. La Nuova Sardegna, 28 Ottobre 1972, Intervento di Eliseo Spiga.
16. La Nuova Sardegna, 4 Agosto 1967, art. cit.
17. La Nuova Sardegna, 2 Settembre 1965, Fidel.
18. Relazione al Convegno di Ollolai, cit. al punto 6.
19. La Nuova Sardegna 18 Agosto 1971, Intervento di Mario Melis.
20. Lettera ad Anselmo Contu l’11 Novembre 1967 ora in “Sardisti” op. cit. pag.481-494.
21. Tesi di Riggio, op. cit. pag.17
22. “L’Autonomia politica della Sardegna” – Nota critica introduttiva – Ed. Sardegna libera, Sassari 1966.
23. La Nuova Sardegna 20 Agosto 1965, ora in “Sardisti” op. cit. pag.458
24. La Nuova Sardegna 2 Settembre 1965, op. cit.
25. La Nuova Sardegna 11 Agosto 1967, Intervento di Fidel.
26. Ibidem.
27. “Il Partito sardo d’azione e la lotta di liberazione anticolonialista” in Sardegna libera, anno1° n.2 Aprile 1971, Sassari.
28. Ibidem
29. Gian Franco Contu, Sa Republica Sarda, Dicembre 1971.
30. Gaspare Barbiellini Amidei, Corriere della sera, 1° e 8 Dicembre 1971.
31. La Nuova Sardegna, 18 Agosto 1971, op. cit.
32. Sardisti, op. cit. pag. 449-450.
33. La Nuova Sardegna 18 Agosto 1971, Intervento di G. B. Melis.
34. La Nuova Sardegna 8 Agosto 1972, Intervento di Michelangelo Pira.
35. La Nuova Sardegna 11 Agosto 1967 Intervento di Fidel.
36. La Nuova Sardegna, 25 Luglio 1972.
37. La Nuova Sardegna,20 Maggio 1973, Intervento di Antonello Satta.
38. Sardegna Libera, Aprile 1971.
39. Ibidem.
40. Ibidem.
41. La Nuova Sardegna, 28 Ottobre 1972,Intervento di Eliseo Spiga, op. cit.ù
42. Ibidem
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1) Dante, “Inferno, verso 105”
2) J. G. Ficte, “Discorsi alla nazione tedesca, 1807/8)
3) Alessandro Manzoni “lirica Marzo 1821, versi 31-32”
4) Federico Chabod “L’idea di nazione, 1961”
5) Mario Albertini “Lo stato nazionale, 1960”
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1) Ernesto Ragionieri, “Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita” Bari 1967
2) Giorgio Candeloro, “Storia dell’Italia moderna. La costruzione dello stato unitario” vol. V, ed. Feltrinelli, Milano 1968
3) Antonio Gramsci, “Il Risorgimento”, Ed Einaudi, Torino 1955
4) Rosario Romeo, “Dal Piemonte sabaudo all’Italia liberale”, Torino 1963
5) Alberto Caracciolo, “La formazione dello stato moderno” Bologna 1970 e “Stato e società civile: Problemi dell’unificazione italiana” Torino 1960
6) Carlo Ghisalberghi, “Sulla formazione dello stato moderno in Italia” Milano 1967
7)Luigi Manconi, Unione Sarda 13.19-1983
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1)Renzo Del Carria-Claudio De Boni, “Gli Stati Uniti d’Italia” ed. D’Anna, Ancona-Mressina 1991
2) Questa citazione come tutte le altre che seguiranno sono tratte dal volume citato al punto 1di Del Carria-De Boni
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1) Emilio Lussu, “ Rivista Giustizia e liberta”, n.6 de 1933
2) Norberto Bobbio “Federalismo, Introduzione a Silvio Trentin”.
3) Questa citazione come tutte le altre che seguiranno sono tratte da “Giustizia e libertà” (Vedi punto 1)